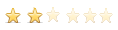È indubbiamente un tema delicato, lo è in questa connotazione –se possibile ancora di più- per i tratti dei drammi personali che sono scaturiti, ed infine lo è per me in quanto ultima frontiera di dinamiche che suscitano il mio interesse.
Quanto la condizione di morte biologica sia in grado di omologare, è forse bene sia lasciato alle sensibilità individuali.
È invece la negazione inconscia delle sue caratteristiche salienti che forse può costituire il centro gravitazionale di riflessioni riferite ad un ambito estremamente variegato, seppur in qualche modo scientificamente avvicinabile.
Si tratta però di una negazione indiretta, sottintesa da un’affermazione, quasi una progettualità che ascrive a quella condizione l’obiettivo, lo status, di quiete; scevro da ogni tensione, da ogni frustrazione, da ogni insopportabile conflitto.
Una progettualità che afferma nuovamente la propria identità prefiggendosi quasi un non distacco, un perdurare emotivo in coloro i quali –a vario titolo- sono collocabili nella sfera affettiva del suicida.
Una progettualità, che prevede anche –nel gesto estremo- un aspetto comunicativo -ergo relazionale- che assume anche tratti rivendicatori, accusatori, quand’anche sottintesi.
Questo, non di rado può essere rilevato dalle note che il suicida spesso redige prima del gesto.
Risulta di nuovo opportuno un repentino cambio di focale passando da evidenziazioni generali a quelle particolari per non perdere di vista la necessità di declinare il suicidio al plurale; contemplando quindi per esso, tratti variabili come quelli evidenziabili tra gesto patologico e quello razionale (che in realtà quantitativamente fatica non in tutti, ma in molti casi, a conservare tale qualità).
Perché spesso fatica? Perché un’altra frequente costante è il restringimento dello spettro possibilistico che il soggetto percepisce come attuabile per arginare e poi risolvere il disagio che lo abita.
Un restringimento di opzioni che porta inesorabilmente il computo a due, che poi sostanzialmente si identificano in una: quella risoluzione totale e definitiva che in ultima istanza solo la morte può portare.
La razionalità è infinitamente limitata in ciò, e non vi sono appigli, essa null’altro vede, null’altro ammette come ammissibile, a null’altro conferisce valore, a null’altro si interessa.
È appunto –come è stato giustamente citato nel thread- il caso di certi disturbi depressivi maggiori che infatti, presentano un alto tasso di incidenza nelle determinazioni suicide.
Qua vi è lo spazio per intervenire, il dovere di intervenire, la necessità di farlo.
Una riduzione così drastica delle prospettive, delle opzioni, non di rado è infatti un aspetto tutt’altro che inevitabile, ma soggettivo più che oggettivo, più percepito che reale, più statico che dinamico.
Io credo che molti di noi, abbiano la possibilità di attingere ad aspetti esperienziali in grado di fornire una rappresentazione tangibile di quanto sopra.
Credo, che molti, nella propria vita, abbiano sperimentato situazioni estremamente complesse e difficili. Credo che quando razionalmente hanno passato in rassegna le possibilità, le opzioni relative al solving, abbiano trovato anche il suicidio.
Credo che esso, si sia progressivamente affermato sulle altre, per il venir meno delle stesse, per la loro inattuabilità.
Credo vi possano essere molti casi nei quali -chi in presenza di ridotte opzioni operative- sia riuscito a resistere, a permanere in quel grave disagio, abbia ad un certo punto –improvvisamente- sperimentato la condizione nella quale l’orizzonte si è aperto, lo spettro possibilistico ha cessato la propria dimensione dicotomica.
Credo chi ha sperimentato tutto ciò, possa aver maturato a posteriori l’esatta percezione di cosa in realtà il suicidio, meglio: quel gesto specifico, di quella condizione specifica, potesse significare.
Questo è il motivo per il quale è necessario, imperativo intervenire, o almeno prodigarsi nel tentativo.
Si è parlato di un libro, mi permetto di suggerire l’approccio all’illuminante lavoro di Edwin Shneidman.
 Sign In
Sign In Create Account
Create Account


 Viandante Affezionato
Viandante Affezionato