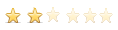Un secolo più tardi Aureliano, coadiutore di Aquileia, apprese che alle rive del Danubio la nuova setta dei monotoni (chiamati anche anulari) affermava che la storia è un circolo e che nulla esiste che non sia già stato e che non sarà nuovamente. Sulle montagne, la Ruota e il Serpente avevano sostituito la Croce. Tutti temevano, ma li confortava la voce che Giovanni di Pannonia, che s’era distinto con un trattato sul settimo attributo di Dio, avrebbe impugnato una così abominevole eresia.
Aureliano deplorò le nuove, soprattutto l’ultima. Sapeva che, in materia teologica, non c’è novità senza rischio; poi rifletté che la tesi di un tempo circolare era troppo dissimile, troppo stupefacente, perché il rischio fosse grave. (le eresie che dobbiamo temere sono quelle che possono confondersi con l’ortodossia) Maggiormente gli dolse l’intervento – l’intrusione – di Giovanni di Pannonia. Due anni prima questi aveva usurpato col suo verboso De septima affectione Dei sive de aeternitate un argomento riservato ad Aureliano; ora come se il problema del tempo gli appartenesse, si apprestava a correggere, forse con argomenti di Procusto, con rimedi più temibili del Serpente, gli anulari… Quella notte, Aureliano sfogliò le pagine dell’antico dialogo di Plutarco sulla fine degli oracoli; al paragrafo ventinove, lesse una beffa contro gli stoici che sostengono un infinito ciclo di mondi, con infiniti soli, lune, Apolli, Diane e Poseidoni. La scoperta gli parve un pronostico favorevole; risolse di precedere Giovanni di Pannonia e di confutare gli eretici della Ruota.
C’è chi cerca l’amore di una donna per dimenticarsi di lei, per non pensare più a lei; Aureliano, allo stesso modo, voleva superare Giovanni di Pannonia per guarire dal rancore che questi gl’infondeva, non per nuocergli. Preso dal lavoro, dalla costruzione di sillogismi e dall’invenzione di ingiurie, dai nego, gli autem e i nequaquam, dimenticò il rancore. Eresse vasti e quasi inestricabili periodi, folti d’incisi, dove la negligenza e l’errore parevano forme del disdegno. Della cacofonia si fece uno strumento. Previde che Giovanni avrebbe fulminato gli anulari con gravità profetica; optò, per non coincidere con lui, per lo scherno. Agostino aveva scritto che Gesù è la via retta che ci salva dal labirinto circolare nel quale vagano gli empi; Aureliano, laboriosamente comune, li paragonò a Issione, al fegato di Prometeo, a Sisifo, a quel re di Tebe che vide due soli, alla balbuzie, a pappagalli, ad echi, a mule di noria e a sillogismi bicornuti. (Le favole dei gentili duravano ancora, ridotte a ornamento.) Come tutti coloro che possiedono una biblioteca, Aureliano si sapeva colpevole di non conoscerla completamente; quella controversia gli permise di compiere un atto riparatore verso molti libri che parevano rimproverargli la sua negligenza. Così poté un passo dell’opera De principiis di Origene, dove si nega che Giuda Iscariota tornerà a vender il Signore, e Paolo ad assistere a Gerusalemme al martirio di Stefano; e un altro degli Accademica Priora di Cicerone, nel quale questi si burla di coloro che sognano che, mentre egli conversa con Lucullo altri Luculli e altri Ciceroni, in numero infinito, dicono esattamente le stesse cose, in infiniti mondi uguali. Infine si valse contro i monotoni del testo di Plutarco, denunciando come scandalo il fatto che sapesse servirsi meglio un idolatra del lumen naturae, che essi della parola di Dio. Nove giorni gli prese quel lavoro; il decimo, gli fu consegnata una copia della confutazione di Giovanni di Pannonia.
Era quasi irrisoriamente breve; Aureliano la guardò con disdegno poi con timore. La prima parte glossava i versetti finali del nono capitolo dell’Epistola agli Ebrei, dove si dice che Gesù non fu sacrificato molte volte dal principio del mondo, ma una sola nella consumazione dei secoli. La seconda citava il precetto biblico sulle vane ripetizioni dei gentili (Matteo, 6:7) e quel passo del settimo libro di Plinio, che sostiene che nel vasto universo non vi sono due face uguali. Giovanni di Pannonia affermava che neppure ci sono due anime uguali e che il peccatore più vile è prezioso quanto il sangue sparso per lui da Gesù Cristo. L’atto di un solo uomo (affermava) pesa più che i nove cieli concentrici e fantasticare che possa perdersi e ripetersi è una complicata sciocchezza. Il tempo non torna a fare ciò che perdiamo; l’eternità lo conserva per il gaudio o per il fuoco eterni. Il trattato era limpido, universale; non sembrava scritto da una persona concreta, ma da un qualunque uomo, o forse da tutti gli uomini.
Aureliano sentì un’umiliazione quasi fisica. Pensò di distruggere o di modificare il proprio lavoro; poi, con vendicativa probità, lo mandò a Roma senza mutarvi una virgola. Mesi più tardi, quando si riunì il concilio di Pergamo, il teologo incaricato di impugnare gli errori monotoni fu, com’era da prevedere, Giovanni di Pannonia; la sua dotta e misurata confutazione bastò perché Euforbo, eresiarca, fosse condannato al rogo. "Questo è occorso e tornerà ad occorrere", disse Euforbo. "Non accendete un fuoco ma un labirinto di fuoco. Se si unissero qui tutti i roghi che io sono stato, non basterebbe la terra a contenerli e gli angeli rimarrebbero ciechi. Questo, l’ho detto molte volte." Poi gridò , perché le fiamme lo raggiunsero. La Ruota cadde davanti alle Croce, ma Aureliano e Giovanni continuarono la loro lotta segreta. Militavano entrambi nello stesso esercito, bramavano lo stesso premio, guerreggiavano contro lo stesso Nemico, ma Aureliano non scrisse una sola parola che inconfessabilmente non tendesse a superare Giovanni. Il loro duello fu invisibile; sei copiosi indici non mi ingannano, non una volta il nome dell’altro figura nei molti volumi di Aureliano conservati nella Patrologia di Migne. (Delle opere di Giovanni, non sono rimaste che venti parole.) Ambedue disapprovarono gli anatemi del secondo concilio di Costantinopoli; ambedue perseguitarono gli ariani, che negavano la generazione eterna del Figlio; ambedue attestarono l’ortodossia della Topographia Christiana di Cosmas, che insegna che la terra è quadrangolare, come il tabernacolo. Disgraziatamente, pei quattro angoli della terra si sparse un’altra tempestosa eresia. Originaria dell’Egitto o dell’Asia (giacché le testimonianze differiscono e Bousset non vuole ammettere le ragioni di Harnack), infestò le province orientali ed eresse santuari in Macedonia, a Cartagine e a Treviri. Parve trovarsi dappertutto; si disse che nella diocesi di Britannia erano stati capovolti i crocifissi e che l’immagine del Signore, in Cesarea, era stata soppiantata da uno specchio. Lo specchio e l’obolo erano gli emblemi dei nuovi scismatici.
La storia li conosce sotto vari nomi (speculari, abissali, cainiti), ma di tutti il più fortunato è quello di istrioni, che Aureliano dette loro e che essi temerariamente adottarono. In Frigia li dissero simulacri, e così in Dardania. Giovanni Damasceno li chiamò forme; ma è bene avvertire che il passo è stato rifiutato da Erfjord. Non c’è eresiologo che non riferisca con stupore i loro stravaganti costumi. Molti istrioni professarono l’ascetismo; qualcuno si mutilò come Origene; altri vissero sotto terra, nelle cloache; altri si strapparono gli occhi; altri (i nabucodonosori di Nitria) "pascevano come buoi e sul loro corpo cresceva una peluria come d’aquila." Dalla mortificazione e dal rigore passavano, spesso al delitto; certe comunità tolleravano il furto, altre, l’omicidio; altre la sodomia, l’incesto e la bestialità. Tutte poi erano blasfeme, e maledicevano non solo il Dio cristiano ma anche le arcane divinità del loro Panteon. Tramarono libri sacri la cui scomparsa è deplorata dai dotti. Sir Thomas Browne, intorno al 1658, scrisse: "Il tempo ha annientato gli ambiziosi Vangeli istrionici, non le ingiurie con cui si fustigò la loro Empietà"; Erfjord ha suggerito che le "ingiurie" (conservate in un codice greco) possano essere gli evangeli perduti. Ciò è incomprensibile, se si ignora la cosmologia degli istrioni.
Nei libri ermetici è scritto che quel che sta in basso è uguale a quel che sta in alto, e quel che sta in alto è uguale a quel che sta in basso; nello Zohar, che il mondo inferiore è un riflesso di quello superiore. Gli istrioni fondarono la loro dottrina su un pervertimento di quell’idea. Invocarono Matteo, 6:12 ("rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori") e 11.12 ("il regno dei cieli patisce violenza") per dimostrare che la terra influisce sul cielo; e la prima epistola ai Corinzi, 13:12 ("ora vediamo attraverso uno specchio, in enigma") per sosteneva che quanto vediamo è falso. Contagiati forse dai monotoni, immaginarono che ogni uomo è due uomini e che il vero è l’altro, quello che sta in cielo. Immaginarono anche che i nostri atti gettino un riflesso invertito, di modo che se noi vegliamo, l’altro dorme, se fornichiamo, l’altro è casto, se rubiamo. L’altro da del suo. Morti, ci riuniremo a lui e saremo lui. (un’eco di tali dottrine perdura in Bloy.) Altri istrioni sostennero che il mondo avrebbe avuto fine quando si fosse esaurito il numero della sue possibilità; giacché non possono esservi ripetizioni, il giusto deve eliminare (commetter) gli atti più infami, affinché questi non macchino il futuro e per affrettare l’avvento del regno di Gesù. Questo articolo fu negato da altre sette, le quali sostennero che la storia del mondo deve compiersi in ogni uomo. I più, come Pitagora, dovranno trasmigrare attraverso molti corpi prima di ottenere la loro liberazione; alcuni, i proteici, "nel termine d’una sola vita sono leoni, sono dragoni, sono cinghiali, sono acqua e sono albero." Demostene narra la purificazione per mezzo del fango alla quale erano sottoposti gl’iniziati ai misteri orfici; i proteici, per analogia, cercarono al purificazione per mezzo del male. Cedettero, come Carpocrate, che nessuno uscirà dal carcere prima di pagare fino all’ultimo obolo (Luca, 12:59), ed erano soliti abbagliare i penitenti con quest’altro versetto: "Sono venuto affinché gli uomini abbiano vita e l’abbiano in abbondanza" (Giovanni, 10:10). Dicevano anche che non essere malvagi è un atto di superbia satanica… Molte e divergenti mitologie ordirono gl’istrioni: gli uni predicarono l’ascetismo, gli altri la licenza, tutti la confusione. Teopompo, istrione di Berenice, negò tutte le favole; disse che ciascun uomo è un organo che la divinità proietta per sentire il mondo.
Gli eretici della diocesi di Aureliano erano di quelli che affermavano che il tempo non tollera ripetizioni, non di quelli che affermavano che ogni atto si riflette in cielo. La circostanza era insolita; in una relazione alle autorità romane, Aureliano la menzionò. Il prelato che avrebbe ricevuto la relazione era confessore dell’imperatrice; nessuno ignorava che quel ministero esigente gli vietava le intime delizie della teologia speculativa. Il suo segretario – antico collaboratore di Giovanni di Pannonia, ora inimicatosi con lui – godeva della fama di tenace inquisitore di eterodossie; Aureliano aggiunse un’esposizione dell’eresia istrionica, così come appariva nelle sette di Genova e d’Aquileia. Stese alcuni paragrafi; quando volle scrivere la tesi atroce che non ci sono due istanti uguali, la sua penna si fermò. Non trovò la formula necessaria; gli enunciati della nuova dottrina ("Vuoi vedere cosa non vista da occhi umani? Guarda la luna. Vuoi udire cosa non udita da orecchio? Ascolta il grido dell’uccello. Vuoi toccare cosa non toccata da mano? Tocca la terra. In verità io dico che Dio deve ancora creare il mondo") erano troppo artificiosi e metaforici per essere trascritti. All’improvviso una frase di venti parole si presentò al suo spirito. La scrisse, gioioso; subito dopo, lo turbò il sospetto che fosse d’altri. Il giorno seguente, ricordò che l’aveva letta molti anni prima nell’Adversus anulares che aveva composto Giovanni di Pannonia. Controllò la citazione; era là. L’incertezza prese a tormentarlo. Variare o sopprimere quelle parole significava indebolire l’espressione; lasciarle, era plagiare un uomo ch’egli aborriva; indicare la fonte equivaleva a denunciarlo. Implorò il soccorso divino. All’inizio del secondo crepuscolo, il suo angelo custode gli dettò una soluzione intermedia. Aureliano conservò le parole, ma premise loro questo avvertimento: Quel che ora latrano gli eresiarchi a confusione della fede, lo disse in questo secolo un uomo dottissimo, con più leggerezza che colpa. Poi, accadde il temuto, l’atteso, l’inevitabile. Aureliano dovette dichiarare chi era quell’uomo; Giovanni di Pannonia fu accusato di professare opinioni eretiche.
Quattro mesi dopo, un fabbro dell’Aventino, allucinato dagl’inganni degli istrioni , collocò sulle spalle del figlioletto una grande sfera di ferro, perché il suo "doppio" volasse. Il bambino morì; l’orrore generato dal delitto impose una severità senza pari ai giudici di Giovanni. Questi non volle ritrattarsi; ripeté che negare la sua proposizione equivaleva ad incorrere nella pestilenziale eresia dei monotoni. Non capì (non volle capire) che parlare dei monotoni era parlare di cosa dimenticata. Con insistenza alquanto senile, prodigò i periodi più brillanti delle sue vecchie polemiche; i giudici neppure ascoltavano argomenti che una volta li avevano affascinati. Invece di cercare di purificarsi della più lieve macchia d’istrionismo, Giovanni si sforzò di dimostrare che la proposizione di cui lo accusavano era rigorosamente ortodossa. Discusse con gli uomini dal cui verdetto dipendeva la sua sorte, e commise l’estremo errore di farlo con ingegno e ironia. Il ventisei ottobre, al termine d’una discussione durata tre giorni e tre notti, lo condannarono a morire sul rogo.
Aureliano assistette all’esecuzione, perché il non assistervi avrebbe significato confessarsi colpevole. Il luogo del supplizio era una collina, sulla cui verde cima era un palo, conficcato profondamente nel suolo, e intorno molti fastelli di legna. Un ministro lesse la sentenza del tribunale. Sotto il sole di mezzogiorno, Giovanni di Pannonia giaceva con la faccia nella polvere, lanciando urla bestiali. Graffiava la terra, ma i carnefici lo strapparono dal suolo, lo spogliarono e infine lo legarono al legno. Sulla testa gli posero una corona di paglia cosparsa di zolfo; accanto, un esemplare del pestilente Adversus anulares. Era piovuto la notte, e la legna ardeva male. Giovanni di Pannonia pregò in greco e poi in un idioma sconosciuto. Il rogo stava per prenderselo, quando Aureliano osò alzare gli occhi. Le lingue ardenti si arrestarono; Aureliano vide per la prima e l’ultima volta il volto dell’odiato. Gli ricordò quello di qualcuno, ma non poté precisare di chi. Poi le fiamme lo perdettero; gridò, e fu come se un incendio gridasse.
Plutarco ha narrato che Giulio Cesare pianse la morte di Pompeo; Aureliano non pianse quella di Giovanni, ma provò quello che proverebbe un uomo guarito da una malattia incurabile, che fosse ormai parte della sua vita. In Aquileia, in Efeso, in Macedonia, lasciò che su di lui passassero gli anni. Cercò gli ardui confini dell’Impero, le lente paludi e i contemplativi deserti, perché la solitudine lo aiutasse a comprendere il proprio destino. In una cella della Mauritania, nella notte folta di leoni, ripensò alla complessa accusa contro Giovanni di Pannonia e giustificò per l’ennesima volta, il giudizio. Più fatica gli costò giustificare la sua tortuosa denuncia. In Rusaddir predicò l’anacronistico sermone Luce delle luci accesa nella carne di un reprobo. In Ibernia, in una delle capanne d’un monastero circondato dalla selva, lo sorprese una notte, verso l’alba, il rumore della pioggia. Ricordò una notte romana in cui, allo stesso modo, l’aveva sorpreso quel minuzioso rumore. Un fulmine a mezzogiorno, incendiò gli alberi, e Aureliano morì com’era morto Giovanni.
 Sign In
Sign In Create Account
Create Account


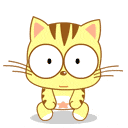
 Viandante Residente
Viandante Residente