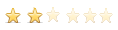.
Nu’ bellu cafè
Marchigiano, con la prospettiva di rimanere a Napoli per gran parte almeno della vita, a dodici anni cercai d’integrarmi nel contesto sociale della città che mi aveva accolto nel suo sole, nei suoi profumi, nella sua unica ed inequivocabile filosofia. E cominciai ad assaggiare e capire il caffè.
Perché a Napoli, diversamente che in ogni altro punto del globo, il caffè non è una bevanda, non un eccitante, e nemmeno il digestivo rituale del fine-pranzo… si, è anche queste cose ma in second’ordine, sfumate su un panorama di ben altre intense sensazioni, emozioni, rapporti.
Il caffè, pur nella sua natura così concretamente individuata di capolavoro in tazzina, è un alito di vita, un messaggio d’amore e, come precisavo, soprattutto una pennellata di luce nel quadro stupendo della filosofia e dell’animo partenopeo. E va quindi si bevuto, sorbito, centellinato; ma soprattutto capito, approfondito nel messaggio che trasporta in se: ogni volta diverso.
Mi chiedeva, tempo fa, un amico deliziosamente provocatorio: «Ma in tanti anni che sei stato a Napoli, hai almeno imparato a fare il caffè?…». Delizioso, il mio amico, perché da buon napoletano sa bene che è una domanda da non farsi se non per celia, provocatorio per il mettere alla prova la mia arguzia. Se gli rispondo “si”, sbaglio perché dimostro di non aver capito niente del caffè, e se gli rispondo “no”, rinnego il cuore vivo di un popolo che ha battuto insieme col mio, senza scartarmi o ignorarmi mai per quarant’anni di fila. Per conoscermi meglio, il mio amico mi interroga sulla mia napoletaneità .
No, professore (il mio amico insegna al liceo), lo so bene che a Napoli il caffè non “s’impara a farlo” come si può magari imparare a fare un risotto alla milanese o un corretto sonetto in endecasillabi alterni. Il caffè a Napoli si vive, si interpreta, si “sente”…
Cioè, per spiegarmi rimanendo in argomento, fra “un caffè ” e “‘o Ccafè” c’è pari differenza che fra un sonetto acrostico ed una poesia: l’uno può essere anche l’altra… ma non è detto che lo sia.
Dovremo ritornare, credo, su quest’argomento, perché merita un accurato approfondimento. Forse sarà il caso di scrivere un saggio su “Il linguaggio d’ ‘o Ccafè”, e non sarà cosa da poco. Ma ora procediamo per la nostra strada e parliamo del caffè a Napoli. Il mio contributo a questa cultura sarà il raccontare umilmente quello che ho capito durante la mia permanenza nella fascinosa Sirena del Golfo.
Per quanto mi riesce di schematizzare, esistono a Napoli almeno tre differenti, contrastanti e fra loro ostili correnti di pensiero. Ognuna con variazioni e sfumature molteplici; queste ce le perderemo quasi tutte, purtroppo.
Le correnti sono: quella “della macchinetta”, quella “del Bar”, e quella “dell’espresso”. Tre modi di fare il caffè, tre bevande diverse, tre diverse occasioni di socialità.
Primo, la macchinetta. Unanimamente riconosciuto come il più classico ed autentico caffè napoletano, quello della macchinetta va purtroppo scomparendo. Colpa, direbbero questa volta giustamente “verdi” e ambientalisti, della distruzione dell’abitat naturale di questo rito vivente, sensibile come ogni vivente all’ecologia dell’ambiente circostante.
Ricordate Eduardo nel celeberrimo monologo sul balconcino della casa del vicolo? In “questo” caffè c’è il vicolo, il balconcino, Eduardo, le sue espressioni e la filosofia che sottende: l’anima di Napoli. E, solo uno fra gli altri ingredienti, naturalmente il caffè.
Per fare questo caffè occorrono alcune cose.
La “macchinetta” anzitutto, che è quella tipica, in alluminio in quattro pezzi: bollitore dell’acqua e bricchetto con beccuccio ne costituiscono l’involucro esterno, portacaffè e filtro stretto a vite il misterioso corpo interno, quello che serve a far la differenza fra “’o cafè” e “’a ciofeca”. In questo corpo, per come riempire il portacaffé e con quale quantità di macinato, per effetto di diversa pressatura si riconosce il caffè di mammà da quello fatto da papà… “che è tutto n’ata cosa!…”.
La macchinetta è anche oggetto di particolari trattamenti. Quando è nuova va “ingignata” (noi informatici diremmo “inizializzata”) con un paio di “giri a vuoto” con l’aceto, per purificare l’alluminio e il successivo accurato, suo unico vero lavaggio. Infatti non la si laverà più, andrà solo accuratamente sciacquata con acqua fresca ad ogni, frequente, utilizzo. Con l’uso prolungato la macchinetta maturerà lentamente, come le pipe di certi cultori del fumo nobile, ed assorbirà fragranze particolari, ma anche attenzioni e cure, divenendo oggetto sacro in una liturgia pagana quotidiana.
Il macinato di caffè a Napoli si chiama “’a pòvere” ma non è polvere, anzi la sua granulometria, attentamente valutata, è una fondamentale “specialità dell’arte”. Per il caffè con la macchinetta, la macinatura deve avvenire al momento della sua preparazione. Per la scelta del macinino non conosco regole particolari: o non ce ne sono o questa è una mia lacuna di forestiero.
Poi ci vuole l’altra macchinetta, non meno importante. Quella per tostare i grani. Infatti il caffè da usare nella “macchinetta” va comprato verde, e la miscela delle qualità è segreto fra la massaia ed il suo droghiere, definita dopo attente valutazioni, e diverrà parte del corredo personale, come l’arte del ricamo o la bravura nel fare il ragù (ragout, in dialetto).
Di queste macchinette ne esistono di due tipi. Uno, più antico, a forma di cilindro da far senza sosta ruotare intorno all’asse sulla sua “fornacella” di carboni ardenti finché i chicchi siano tostati al punto giusto. L’altro, simile ad una padella col suo coperchio saldato sul bordo e munito di uno sportellino per il carico dei chicchi e di ispezione; al centro del coperchio una manovella comanda una paletta interna per il rimescolamento ininterrotto del prezioso carico.
Non ho mai saputo ci fosse una preferenza per l’uno o l’altro tostino, ma va notato che il tostino porta anche due messaggi, oltre che cuocere i grani. Un messaggio amicale: col profumo che effonde fa sapere a tutto il vicinato che fra poco sarà pronto il caffè e (per chi può) è il caso di profittare. Ed uno, più sottile, di contenuto sociale: più spesso tosto il caffè, più sono attenta alle cose di casa e buona massaia, più sono ricca, più sono disponibile verso gli ospiti.
Chi ha orecchie da intendere…
Infine il rito della preparazione. Non entrerò certo in competizione con Eduardo, con la sua mimica e la sua arte, il “coppetto” di carta e l’inesistente vicino da lui evocato ed assai più visibile di tante persone presenti in carne ed ossa… Ha già detto tutto lui, ripassatevi la scena.
Ricorderò solo che la preparazione è lenta e meticolosa e… “ce vo’ ‘o tiempo ca nce vo’”. Tempo essenziale, da dedicare con attenzione ed amore, sennò… “…nun è café!”.
Diverso per molti aspetti tecnici, ma intimamente legato al caffè “della macchinetta” in certe logiche filosofie, e mi verrebbe quasi da dire nella “religiosità”, è il caffè “del Bar”.
Da quello che ho capito io, a Napoli esistono due tipi di esercizi commerciali che, quasi omonimi, sono intimamente dissimili ed orientati a funzioni sociali molto diverse:
Il Bar, che in inglese significa stanga, asse, bancone… ma anche separazione, divisione, divieto, è l’equivalente al Bar di ogni altra parte del mondo, ed è locale di ristoro, pasticceria, rosticceria, chiosco di bevande fresche e luogo di riferimento per appuntamenti, e… “o Bbarr”.
Quest’ultimo ha assunto tale denominazione recentemente, e più propriamente andrebbe chiamato “o Ccafè” con due “Ci” ed una sola “effe”, ed è un ambiente tipicamente napoletano, in qualche modo forse avvicinabile agli “Heurighe” austriaci o a qualche “Stube” ungherese, ma del tutto diverso da ogni altro tipo di locale moderno. Ed ha una funzione diversa
Infatti, in questa difformità di ottica, l’andare a “prendere un caffè” con l’amico, o il Direttore o la conoscenza occasionale, a Napoli non sposa l’esigenza di un corroborante, e nemmeno a quella di un attimo di pausa, di distensione (“breack” lo chiamano gli anglosassoni), ma al contrario sottolinea un delicato momento di particolare emotività e attenzione, cardine di rapporti e di informali raffronti, di nuovi e si spera proficui contatti.
Andare a prendere un caffè insieme al Bar, lungi dall’essere momento di relax, a Napoli equivale ad una dichiarazione di compromesso del tipo “… abbandoniamo per un attimo formalismi ed ipocrisie: mettiamoci uno di fronte all’altro in garanzia di riservatezza e diciamoci sinceramente quello che davvero vogliamo dirci”.
L’ambiente pubblico diventa un confessionale sicuro con il “barista” ne fa parte come testimone, consigliere e talvolta arbitro, un posto riservato, garantito e discreto dove accelerare o chiarire rapporti, risolvere “brevi manu” problemi intricati, gettare basi di future alleanze o lanciare, ed incassare in campo neutro, dichiarazioni di guerra.
Naturalmente accettare o meno l’invito “Jamm’ce a piglià nu cafè!” comporta la consapevolezza di queste regole, l’accettazione aprioristica di un momento, diciamo così… d’intimità controllata. Perché non dimentichiamo che siamo in un luogo pubblico, e c’è il “barrista” custode e garante della liceità e dell’onore del suo locale. Il “…che ccà nun vulimme schifezze!” ha un significato molto, molto più ampio del riferimento alla pulizia o alla correttezza dell’esercizio commerciale. Io ritengo che l’espressione abbia origini più profonde, forse in antichi e mai del tutto abrogati patti d’onore e strette di mano impegnative fatti in posti specifici alla presenza di “probi viri” di altre realtà sociali. “O Bbarr” è luogo quasi sacro, dove puoi si “allargarti” alquanto e dire cose che non oseresti dire in ambienti più ufficiali, ma al contempo te ne assumi anche ogni responsabilità.
E’ un posto serio: puoi esprimere il tuo dissenso al “Capo” senza che lui debba necessariamente adombrarsene, puoi esprimere la tua passione alla segretarietta senza che ci sia “spamming” e lei sia libera di dirti di si o no, puoi risolvere il problema col collega senza che si definisca a priori chi ha avuto ragione e chi torto eccetera…. ma quello che si è detto lì,… si è detto!
Testimone di ogni cosa il “barrista”; sugello di quanto accade, naturalmente lui: “o Ccafè”.
Il caffè del Bar deve essere quindi particolare. Perché lui ed il suo creatore (il barista) sono portatori di molti valori, di speranze, di promesse. Come ho detto dianzi.
Ed allora la tostatura e la miscelazione del caffè saranno personalizzati (una volta!… purtroppo!) Bar per Bar, barista per barista. E la preparazione sarà accuratissima: tazzina calda al punto giusto, umida di vapore (si asciugherà da sola durante l’opera) ma non bagnata, che sennò (giustamente) il cliente non torna, rifornita della giusta quantità di zucchero “prima” che il caffè cominci a gocciolare dal beccuccio perché lo shock termico dello zucchero aggiunto rovina la cremosità… a proposito il “barista” napoletano non conosce diete e diabete, e non concepisce che qualcuno il caffè lo beva amaro. Se lo chiedi te lo fa pure, amaro, ma ti guarda con una faccia… da farti passare la voglia!
E le due dita d’acqua di contorno; da bere rigorosamente prima del caffè per ripulire il cavo orale da eventuali impurità e prepararsi ad una degustazione corretta. Non come i bolognesi, che l’acqua la bevono “dopo”, per sciacquarsi la bocca!… Ma forse hanno pure ragione, con quello loro….
Naturalmente, di macinazione, quantità di caffè e tecnica di riempimento del filtro, pressione del pistone, stop dell’erogazione eccetera non è il caso di parlare! sono intimità gelosamente riservate, e come delle mutandine delle monache, e non se ne fa cenno mai.
Il caffè del Bar, ed il suo barista, hanno infine un’ultima funzione: quella di ammortizzatore sociale.
Dicevo che il Bar è testimone complice di mille incontri e mille affari; che possono andar bene o anche male. E talvolta capita di sentir dire, da clienti anche affezionatissimi:
«’on Frà’… oggi ajte fatto nù cafè… ma proprio n’a munnezza!!»… E don Franco non si offende ma, malinconico e partecipe, sorride come cercando di consolare. E’ andato male l’incontro, ed il cliente deve sfogare il suo disappunto, ma domani certamente tornerà.
Ed ecco che diviene è chiaro anche il titolo di queste righe. A Napoli si dice “nu bellu Ccafè” e non “nu bbuono Ccafè” non perché non si abbia proprietà di linguaggio, ma al contrario, per un più raffinato uso dell’aggettivo. Bello, in napoletano come in italiano infatti, ha nel traslato un significato più ampio di buono, travalicando di molto la specificazione del senso. Ha i connotati dell’augurio, del bene, del soddisfacente. E così “nu bellu Ccafè” è quello che ha accompagnato l’affare concluso, la segretarietta sedotta, l’amicizia riconciliata. Quello cioè che al di la della sua gustosità sarà da ricordare per essersi accompagnato ad altre positività.
Non c’è rimasto che l’ultimo caffè, quello dell’ “espressa”, mostruosità linguistica che un po’ rievoca i trasporti, cioè le ferrovie dello stato confondendo gli irrispettosi treni senza fermate intermedie con quella che è stata una delle migliori ispirazioni umane: “‘a tazzulella”.
C’è un aggeggio in alluminio pressofuso, brevetto e vanto della tecnologia italiana e presente anche al “New York museum” come esempio egregio di disegno industriale, che serve per fare il caffè espresso (che significa solo “preparato in quel momento”, come ogni altro caffè).
E’ questo uno strumento quasi magico. In pochissimi minuti, con una qualsiasi delle molteplici polverine offerte (a caro prezzo) in coloratissimi cartocci di alluminio sui banchi di ogni supermercato, riesce a produrre un liquido più o meno brunastro, più o meno schiumoso ed aromatico che, edulcorato o meno con ogni tipo di schifezza, arricchito di liquori, nocciole, creme, burri o altre cose, viene spacciato da molti come “caffè alla napoletana”.
Naturalmente dargli questo nome è una barzelletta. Ma triste è che non faccia ridere più nessuno, e quotidianamente quest’indegno intruglio lo ingolliamo tutti, a litri e a galloni. Caldo, freddo, riscaldato nel forno a microonde… E tristissimo è che non ce ne lamentiamo nemmeno.
A Napoli, andare in un Bar invece che in un altro fa la differenza fra un raffinato e uno zotico, un artista e un manovale, un gentiluomo ed un cafardo.
Con la “Bialetti” chi vuoi che si accorga se nell’incolpevole passino sia stata messa macinatura di caffè, o di orzo, o di ceci o cicerchie lupini o fave?… O magari torba o il terriccio universale che è avanzato dal rinvaso delle piantine?… Tanto poi dentro ci metteremo la saccarina, sopra un bel cappuccio di panna, naturalmente vegetale e montata con gas carbonico, decoreremo il tutto con grattata di succedaneo di cacao, e per condimento, subito, un bell’ammazza-caffè da quaranta e più gradi alcolemici!…
E se togliessimo del tutto quell’imbutino forato e mettessimo nell’aggeggio l’acqua con cui abbiamo lessato i carciofi l’altro ieri?
Il colore sarebbe uguale, il sapore meglio e forse avremmo anche qualche complimento per l’originalità! Ammesso che qualcuno noti una qualche differenza di gusto .
Certo almeno che avremmo risparmiato quattrini.
L’attrezzo stesso viene quotidianamente messo in lavastoviglie col detersivo pubblicizzato questo mese, insieme alle altre stoviglie sporche di unti, uova, spezie ed erbe aromatiche, pesci, sali e quant’altro. Giorno dopo giorno nei micropori della pressofusione a conchiglia della caldaietta ove scalderà l’acqua del cosiddetto caffè sedimentano e putrefano stratificandosi in immonda melma feculenta le particelle aromatiche diffuse nell’acqua di lavaggio dai resti di ogni cibo, da mille pietanze diverse. Ritorneranno per insaporire la broda che berremo chiamandola caffè.
Questa è la nostra realtà, ma non ha senso piangerci su. Se non abbiamo più il caffè, se quel rito non è più rito, se quella delizia non ci delizia più, la colpa non è della natura, che il caffè continua a produrlo uguale, non è di Eduardo che dopo ottant’anni si è rotto e se ne è andato, e non è colpa nemmeno del barista, che ormai non ha più orecchie né tazzine calde, ma solo bicchierini di plastica puzzolente e rotelline e fessure per i soldi e bottoncini colorati da spremere in solitudine sulle mute macchinette automatiche.
E non è forse nemmeno colpa nostra, se non c’è più “o Ccafè”. Semplicemente, non serve più.
Ora al bar non ci andiamo più, non sediamo più a scambiarci sguardo ed anima col nostro prossimo, non palpitiamo più per la fanciulla irraggiungibile pur se seduta nel banco accanto. Non contrattiamo più col nostro cliente.
Oggi il nostro ospite lo vediamo sullo schermo del telefonino, e non lo annusiamo più. Lo contattiamo via internet. E l’armonia di amorosi sensi è affidata all’agenzia specializzata ed ai suoi test fisici e psicosomatici computerizzati. Ce lo comunicano loro comodamente e tempestivamente al nostro domicilio se e di chi ci siamo innamorati, e questo mese c’è anche l’offerta speciale: ogni due amanti, un’altra piccola in omaggio per tre giorni.
E il corrispondente in affari si rivolga al mio commercialista; la stretta di mano conclusiva dell’affare glie la farà dare dal suo segretario…
Ma servono ancora, “’sti Ccafè”?… adesso ci sono pure quelli che si portano direttamente in tasca: “Pocket”, si chiamano, e basta scartarli…
Ed allora, a quel mio amico, affettuoso e provocatore, che mi chiedeva se ho imparato a fare il caffè, cosa mai potrò rispondere?
Gli dirò di venire ugualmente a trovarmi, che cercheremo di intenderci e volerci bene lo stesso. Il caffè?… forse glielo farò io, forse lo farà qualcun altro, in casa. Ma non conterà. Sarà certamente gradevole di sapore, denso al punto giusto, caldo come esce dall’attrezzo e con la schiuma che gradisce (sennò c’è pure un frullino che ne fa di più).
Il mio amico avrà un caffè perfetto insomma. Perfettamente identico a come potrebbe trovarlo a Roma o a Milano, a Città del Capo o a Pechino.
E naturalmente potrà facilmente distinguerlo dalla Cocacola e dai panini di McDonalds. Infatti da me è quello servito in tazzine di porcellana bianca col piattino rotondo.
Sarà un caffè, non il mio “Ccafè” fatto apposta per lui.
Lucio Musto 16 giugno 2004 parole 2927
-------------------------------------------------------------------
Nu’ bellu cafè
Marchigiano, con la prospettiva di rimanere a Napoli per gran parte almeno della vita, a dodici anni cercai d’integrarmi nel contesto sociale della città che mi aveva accolto nel suo sole, nei suoi profumi, nella sua unica ed inequivocabile filosofia. E cominciai ad assaggiare e capire il caffè.
Perché a Napoli, diversamente che in ogni altro punto del globo, il caffè non è una bevanda, non un eccitante, e nemmeno il digestivo rituale del fine-pranzo… si, è anche queste cose ma in second’ordine, sfumate su un panorama di ben altre intense sensazioni, emozioni, rapporti.
Il caffè, pur nella sua natura così concretamente individuata di capolavoro in tazzina, è un alito di vita, un messaggio d’amore e, come precisavo, soprattutto una pennellata di luce nel quadro stupendo della filosofia e dell’animo partenopeo. E va quindi si bevuto, sorbito, centellinato; ma soprattutto capito, approfondito nel messaggio che trasporta in se: ogni volta diverso.
Mi chiedeva, tempo fa, un amico deliziosamente provocatorio: «Ma in tanti anni che sei stato a Napoli, hai almeno imparato a fare il caffè?…». Delizioso, il mio amico, perché da buon napoletano sa bene che è una domanda da non farsi se non per celia, provocatorio per il mettere alla prova la mia arguzia. Se gli rispondo “si”, sbaglio perché dimostro di non aver capito niente del caffè, e se gli rispondo “no”, rinnego il cuore vivo di un popolo che ha battuto insieme col mio, senza scartarmi o ignorarmi mai per quarant’anni di fila. Per conoscermi meglio, il mio amico mi interroga sulla mia napoletaneità .
No, professore (il mio amico insegna al liceo), lo so bene che a Napoli il caffè non “s’impara a farlo” come si può magari imparare a fare un risotto alla milanese o un corretto sonetto in endecasillabi alterni. Il caffè a Napoli si vive, si interpreta, si “sente”…
Cioè, per spiegarmi rimanendo in argomento, fra “un caffè ” e “‘o Ccafè” c’è pari differenza che fra un sonetto acrostico ed una poesia: l’uno può essere anche l’altra… ma non è detto che lo sia.
Dovremo ritornare, credo, su quest’argomento, perché merita un accurato approfondimento. Forse sarà il caso di scrivere un saggio su “Il linguaggio d’ ‘o Ccafè”, e non sarà cosa da poco. Ma ora procediamo per la nostra strada e parliamo del caffè a Napoli. Il mio contributo a questa cultura sarà il raccontare umilmente quello che ho capito durante la mia permanenza nella fascinosa Sirena del Golfo.
Per quanto mi riesce di schematizzare, esistono a Napoli almeno tre differenti, contrastanti e fra loro ostili correnti di pensiero. Ognuna con variazioni e sfumature molteplici; queste ce le perderemo quasi tutte, purtroppo.
Le correnti sono: quella “della macchinetta”, quella “del Bar”, e quella “dell’espresso”. Tre modi di fare il caffè, tre bevande diverse, tre diverse occasioni di socialità.
Primo, la macchinetta. Unanimamente riconosciuto come il più classico ed autentico caffè napoletano, quello della macchinetta va purtroppo scomparendo. Colpa, direbbero questa volta giustamente “verdi” e ambientalisti, della distruzione dell’abitat naturale di questo rito vivente, sensibile come ogni vivente all’ecologia dell’ambiente circostante.
Ricordate Eduardo nel celeberrimo monologo sul balconcino della casa del vicolo? In “questo” caffè c’è il vicolo, il balconcino, Eduardo, le sue espressioni e la filosofia che sottende: l’anima di Napoli. E, solo uno fra gli altri ingredienti, naturalmente il caffè.
Per fare questo caffè occorrono alcune cose.
La “macchinetta” anzitutto, che è quella tipica, in alluminio in quattro pezzi: bollitore dell’acqua e bricchetto con beccuccio ne costituiscono l’involucro esterno, portacaffè e filtro stretto a vite il misterioso corpo interno, quello che serve a far la differenza fra “’o cafè” e “’a ciofeca”. In questo corpo, per come riempire il portacaffé e con quale quantità di macinato, per effetto di diversa pressatura si riconosce il caffè di mammà da quello fatto da papà… “che è tutto n’ata cosa!…”.
La macchinetta è anche oggetto di particolari trattamenti. Quando è nuova va “ingignata” (noi informatici diremmo “inizializzata”) con un paio di “giri a vuoto” con l’aceto, per purificare l’alluminio e il successivo accurato, suo unico vero lavaggio. Infatti non la si laverà più, andrà solo accuratamente sciacquata con acqua fresca ad ogni, frequente, utilizzo. Con l’uso prolungato la macchinetta maturerà lentamente, come le pipe di certi cultori del fumo nobile, ed assorbirà fragranze particolari, ma anche attenzioni e cure, divenendo oggetto sacro in una liturgia pagana quotidiana.
Il macinato di caffè a Napoli si chiama “’a pòvere” ma non è polvere, anzi la sua granulometria, attentamente valutata, è una fondamentale “specialità dell’arte”. Per il caffè con la macchinetta, la macinatura deve avvenire al momento della sua preparazione. Per la scelta del macinino non conosco regole particolari: o non ce ne sono o questa è una mia lacuna di forestiero.
Poi ci vuole l’altra macchinetta, non meno importante. Quella per tostare i grani. Infatti il caffè da usare nella “macchinetta” va comprato verde, e la miscela delle qualità è segreto fra la massaia ed il suo droghiere, definita dopo attente valutazioni, e diverrà parte del corredo personale, come l’arte del ricamo o la bravura nel fare il ragù (ragout, in dialetto).
Di queste macchinette ne esistono di due tipi. Uno, più antico, a forma di cilindro da far senza sosta ruotare intorno all’asse sulla sua “fornacella” di carboni ardenti finché i chicchi siano tostati al punto giusto. L’altro, simile ad una padella col suo coperchio saldato sul bordo e munito di uno sportellino per il carico dei chicchi e di ispezione; al centro del coperchio una manovella comanda una paletta interna per il rimescolamento ininterrotto del prezioso carico.
Non ho mai saputo ci fosse una preferenza per l’uno o l’altro tostino, ma va notato che il tostino porta anche due messaggi, oltre che cuocere i grani. Un messaggio amicale: col profumo che effonde fa sapere a tutto il vicinato che fra poco sarà pronto il caffè e (per chi può) è il caso di profittare. Ed uno, più sottile, di contenuto sociale: più spesso tosto il caffè, più sono attenta alle cose di casa e buona massaia, più sono ricca, più sono disponibile verso gli ospiti.
Chi ha orecchie da intendere…
Infine il rito della preparazione. Non entrerò certo in competizione con Eduardo, con la sua mimica e la sua arte, il “coppetto” di carta e l’inesistente vicino da lui evocato ed assai più visibile di tante persone presenti in carne ed ossa… Ha già detto tutto lui, ripassatevi la scena.
Ricorderò solo che la preparazione è lenta e meticolosa e… “ce vo’ ‘o tiempo ca nce vo’”. Tempo essenziale, da dedicare con attenzione ed amore, sennò… “…nun è café!”.
Diverso per molti aspetti tecnici, ma intimamente legato al caffè “della macchinetta” in certe logiche filosofie, e mi verrebbe quasi da dire nella “religiosità”, è il caffè “del Bar”.
Da quello che ho capito io, a Napoli esistono due tipi di esercizi commerciali che, quasi omonimi, sono intimamente dissimili ed orientati a funzioni sociali molto diverse:
Il Bar, che in inglese significa stanga, asse, bancone… ma anche separazione, divisione, divieto, è l’equivalente al Bar di ogni altra parte del mondo, ed è locale di ristoro, pasticceria, rosticceria, chiosco di bevande fresche e luogo di riferimento per appuntamenti, e… “o Bbarr”.
Quest’ultimo ha assunto tale denominazione recentemente, e più propriamente andrebbe chiamato “o Ccafè” con due “Ci” ed una sola “effe”, ed è un ambiente tipicamente napoletano, in qualche modo forse avvicinabile agli “Heurighe” austriaci o a qualche “Stube” ungherese, ma del tutto diverso da ogni altro tipo di locale moderno. Ed ha una funzione diversa
Infatti, in questa difformità di ottica, l’andare a “prendere un caffè” con l’amico, o il Direttore o la conoscenza occasionale, a Napoli non sposa l’esigenza di un corroborante, e nemmeno a quella di un attimo di pausa, di distensione (“breack” lo chiamano gli anglosassoni), ma al contrario sottolinea un delicato momento di particolare emotività e attenzione, cardine di rapporti e di informali raffronti, di nuovi e si spera proficui contatti.
Andare a prendere un caffè insieme al Bar, lungi dall’essere momento di relax, a Napoli equivale ad una dichiarazione di compromesso del tipo “… abbandoniamo per un attimo formalismi ed ipocrisie: mettiamoci uno di fronte all’altro in garanzia di riservatezza e diciamoci sinceramente quello che davvero vogliamo dirci”.
L’ambiente pubblico diventa un confessionale sicuro con il “barista” ne fa parte come testimone, consigliere e talvolta arbitro, un posto riservato, garantito e discreto dove accelerare o chiarire rapporti, risolvere “brevi manu” problemi intricati, gettare basi di future alleanze o lanciare, ed incassare in campo neutro, dichiarazioni di guerra.
Naturalmente accettare o meno l’invito “Jamm’ce a piglià nu cafè!” comporta la consapevolezza di queste regole, l’accettazione aprioristica di un momento, diciamo così… d’intimità controllata. Perché non dimentichiamo che siamo in un luogo pubblico, e c’è il “barrista” custode e garante della liceità e dell’onore del suo locale. Il “…che ccà nun vulimme schifezze!” ha un significato molto, molto più ampio del riferimento alla pulizia o alla correttezza dell’esercizio commerciale. Io ritengo che l’espressione abbia origini più profonde, forse in antichi e mai del tutto abrogati patti d’onore e strette di mano impegnative fatti in posti specifici alla presenza di “probi viri” di altre realtà sociali. “O Bbarr” è luogo quasi sacro, dove puoi si “allargarti” alquanto e dire cose che non oseresti dire in ambienti più ufficiali, ma al contempo te ne assumi anche ogni responsabilità.
E’ un posto serio: puoi esprimere il tuo dissenso al “Capo” senza che lui debba necessariamente adombrarsene, puoi esprimere la tua passione alla segretarietta senza che ci sia “spamming” e lei sia libera di dirti di si o no, puoi risolvere il problema col collega senza che si definisca a priori chi ha avuto ragione e chi torto eccetera…. ma quello che si è detto lì,… si è detto!
Testimone di ogni cosa il “barrista”; sugello di quanto accade, naturalmente lui: “o Ccafè”.
Il caffè del Bar deve essere quindi particolare. Perché lui ed il suo creatore (il barista) sono portatori di molti valori, di speranze, di promesse. Come ho detto dianzi.
Ed allora la tostatura e la miscelazione del caffè saranno personalizzati (una volta!… purtroppo!) Bar per Bar, barista per barista. E la preparazione sarà accuratissima: tazzina calda al punto giusto, umida di vapore (si asciugherà da sola durante l’opera) ma non bagnata, che sennò (giustamente) il cliente non torna, rifornita della giusta quantità di zucchero “prima” che il caffè cominci a gocciolare dal beccuccio perché lo shock termico dello zucchero aggiunto rovina la cremosità… a proposito il “barista” napoletano non conosce diete e diabete, e non concepisce che qualcuno il caffè lo beva amaro. Se lo chiedi te lo fa pure, amaro, ma ti guarda con una faccia… da farti passare la voglia!
E le due dita d’acqua di contorno; da bere rigorosamente prima del caffè per ripulire il cavo orale da eventuali impurità e prepararsi ad una degustazione corretta. Non come i bolognesi, che l’acqua la bevono “dopo”, per sciacquarsi la bocca!… Ma forse hanno pure ragione, con quello loro….
Naturalmente, di macinazione, quantità di caffè e tecnica di riempimento del filtro, pressione del pistone, stop dell’erogazione eccetera non è il caso di parlare! sono intimità gelosamente riservate, e come delle mutandine delle monache, e non se ne fa cenno mai.
Il caffè del Bar, ed il suo barista, hanno infine un’ultima funzione: quella di ammortizzatore sociale.
Dicevo che il Bar è testimone complice di mille incontri e mille affari; che possono andar bene o anche male. E talvolta capita di sentir dire, da clienti anche affezionatissimi:
«’on Frà’… oggi ajte fatto nù cafè… ma proprio n’a munnezza!!»… E don Franco non si offende ma, malinconico e partecipe, sorride come cercando di consolare. E’ andato male l’incontro, ed il cliente deve sfogare il suo disappunto, ma domani certamente tornerà.
Ed ecco che diviene è chiaro anche il titolo di queste righe. A Napoli si dice “nu bellu Ccafè” e non “nu bbuono Ccafè” non perché non si abbia proprietà di linguaggio, ma al contrario, per un più raffinato uso dell’aggettivo. Bello, in napoletano come in italiano infatti, ha nel traslato un significato più ampio di buono, travalicando di molto la specificazione del senso. Ha i connotati dell’augurio, del bene, del soddisfacente. E così “nu bellu Ccafè” è quello che ha accompagnato l’affare concluso, la segretarietta sedotta, l’amicizia riconciliata. Quello cioè che al di la della sua gustosità sarà da ricordare per essersi accompagnato ad altre positività.
Non c’è rimasto che l’ultimo caffè, quello dell’ “espressa”, mostruosità linguistica che un po’ rievoca i trasporti, cioè le ferrovie dello stato confondendo gli irrispettosi treni senza fermate intermedie con quella che è stata una delle migliori ispirazioni umane: “‘a tazzulella”.
C’è un aggeggio in alluminio pressofuso, brevetto e vanto della tecnologia italiana e presente anche al “New York museum” come esempio egregio di disegno industriale, che serve per fare il caffè espresso (che significa solo “preparato in quel momento”, come ogni altro caffè).
E’ questo uno strumento quasi magico. In pochissimi minuti, con una qualsiasi delle molteplici polverine offerte (a caro prezzo) in coloratissimi cartocci di alluminio sui banchi di ogni supermercato, riesce a produrre un liquido più o meno brunastro, più o meno schiumoso ed aromatico che, edulcorato o meno con ogni tipo di schifezza, arricchito di liquori, nocciole, creme, burri o altre cose, viene spacciato da molti come “caffè alla napoletana”.
Naturalmente dargli questo nome è una barzelletta. Ma triste è che non faccia ridere più nessuno, e quotidianamente quest’indegno intruglio lo ingolliamo tutti, a litri e a galloni. Caldo, freddo, riscaldato nel forno a microonde… E tristissimo è che non ce ne lamentiamo nemmeno.
A Napoli, andare in un Bar invece che in un altro fa la differenza fra un raffinato e uno zotico, un artista e un manovale, un gentiluomo ed un cafardo.
Con la “Bialetti” chi vuoi che si accorga se nell’incolpevole passino sia stata messa macinatura di caffè, o di orzo, o di ceci o cicerchie lupini o fave?… O magari torba o il terriccio universale che è avanzato dal rinvaso delle piantine?… Tanto poi dentro ci metteremo la saccarina, sopra un bel cappuccio di panna, naturalmente vegetale e montata con gas carbonico, decoreremo il tutto con grattata di succedaneo di cacao, e per condimento, subito, un bell’ammazza-caffè da quaranta e più gradi alcolemici!…
E se togliessimo del tutto quell’imbutino forato e mettessimo nell’aggeggio l’acqua con cui abbiamo lessato i carciofi l’altro ieri?
Il colore sarebbe uguale, il sapore meglio e forse avremmo anche qualche complimento per l’originalità! Ammesso che qualcuno noti una qualche differenza di gusto .
Certo almeno che avremmo risparmiato quattrini.
L’attrezzo stesso viene quotidianamente messo in lavastoviglie col detersivo pubblicizzato questo mese, insieme alle altre stoviglie sporche di unti, uova, spezie ed erbe aromatiche, pesci, sali e quant’altro. Giorno dopo giorno nei micropori della pressofusione a conchiglia della caldaietta ove scalderà l’acqua del cosiddetto caffè sedimentano e putrefano stratificandosi in immonda melma feculenta le particelle aromatiche diffuse nell’acqua di lavaggio dai resti di ogni cibo, da mille pietanze diverse. Ritorneranno per insaporire la broda che berremo chiamandola caffè.
Questa è la nostra realtà, ma non ha senso piangerci su. Se non abbiamo più il caffè, se quel rito non è più rito, se quella delizia non ci delizia più, la colpa non è della natura, che il caffè continua a produrlo uguale, non è di Eduardo che dopo ottant’anni si è rotto e se ne è andato, e non è colpa nemmeno del barista, che ormai non ha più orecchie né tazzine calde, ma solo bicchierini di plastica puzzolente e rotelline e fessure per i soldi e bottoncini colorati da spremere in solitudine sulle mute macchinette automatiche.
E non è forse nemmeno colpa nostra, se non c’è più “o Ccafè”. Semplicemente, non serve più.
Ora al bar non ci andiamo più, non sediamo più a scambiarci sguardo ed anima col nostro prossimo, non palpitiamo più per la fanciulla irraggiungibile pur se seduta nel banco accanto. Non contrattiamo più col nostro cliente.
Oggi il nostro ospite lo vediamo sullo schermo del telefonino, e non lo annusiamo più. Lo contattiamo via internet. E l’armonia di amorosi sensi è affidata all’agenzia specializzata ed ai suoi test fisici e psicosomatici computerizzati. Ce lo comunicano loro comodamente e tempestivamente al nostro domicilio se e di chi ci siamo innamorati, e questo mese c’è anche l’offerta speciale: ogni due amanti, un’altra piccola in omaggio per tre giorni.
E il corrispondente in affari si rivolga al mio commercialista; la stretta di mano conclusiva dell’affare glie la farà dare dal suo segretario…
Ma servono ancora, “’sti Ccafè”?… adesso ci sono pure quelli che si portano direttamente in tasca: “Pocket”, si chiamano, e basta scartarli…
Ed allora, a quel mio amico, affettuoso e provocatore, che mi chiedeva se ho imparato a fare il caffè, cosa mai potrò rispondere?
Gli dirò di venire ugualmente a trovarmi, che cercheremo di intenderci e volerci bene lo stesso. Il caffè?… forse glielo farò io, forse lo farà qualcun altro, in casa. Ma non conterà. Sarà certamente gradevole di sapore, denso al punto giusto, caldo come esce dall’attrezzo e con la schiuma che gradisce (sennò c’è pure un frullino che ne fa di più).
Il mio amico avrà un caffè perfetto insomma. Perfettamente identico a come potrebbe trovarlo a Roma o a Milano, a Città del Capo o a Pechino.
E naturalmente potrà facilmente distinguerlo dalla Cocacola e dai panini di McDonalds. Infatti da me è quello servito in tazzine di porcellana bianca col piattino rotondo.
Sarà un caffè, non il mio “Ccafè” fatto apposta per lui.
Lucio Musto 16 giugno 2004 parole 2927
-------------------------------------------------------------------
 Sign In
Sign In Create Account
Create Account


 Viandante Ad Honorem
Viandante Ad Honorem
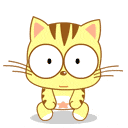


 va ripetuta anche alla macchinetta già usata, ma ferma da un po'.
va ripetuta anche alla macchinetta già usata, ma ferma da un po'.